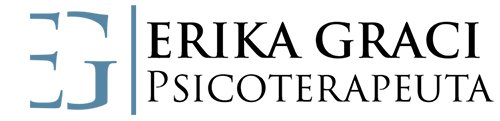10 Giu Un amico in terapia
Ogni paziente è unico.
Quando vado in supervisione mi riferisco a ciascuno individuo che curo con “il mio paziente”.
Non si tratta di un possesso nel senso giuridico del termine, ma faccio riferimento al ruolo che assumo nella sua vita, al mio posto nella sua fragilità, nel suo dolore, nella sua disperazione, nel suo disperato bisogno di aiuto.
Raramente ho conosciuto uno di loro dopo i primo attacco di panico.
Molti, infatti, sono talmente forti senza neppure saperlo, che chiedono aiuto solo dopo aver tentato mille soluzioni ed essersi rialzati dopo mille fallimenti. Se non vogliamo chiamare “forza” questa forma di resilienza qui cosa potremmo epitetate in tal modo?
Ogni paziente ha una rarità da rivelare.
Non esistono pazienti perfettamente sovrapponibili a quelli descritti nei manuali, per cui a ogni prima visita ho il cuore allegro per la scoperta unica che chi mi ha cercato so mi riserverà.
Ieri, però, mi sono ritrovata all’interno di uno dei setting più imprevedibile che io abbia mai potuto immaginare.
E non m’importa cosa ne penserebbe l’Ordine di categoria, Freud, Beck o il mio mito Nardone. Quella seduta resterà, per me, una pietra miliare che non smetterò mai di rievocare, ogni qualvolta disdegnerò l’umanità per la deriva intellettuale che sta prendendo.
Arrivano a studio da quattro splendidi ragazzi sulla ventina. Sembrava passassero sotto il tunnel dello stadio Olimpico, mentre accedevano soltanto alla mia sala di attesa. Io non oppongo alcuna resistenza al mio stupore e li accolgo con un “Chi ha portato il pallone?”.
Così il ghiaccio è stato rotto. Hanno abbassato le spalle tese, mi hanno guardato negli occhi e qualcuno è riuscito anche a sorridermi. È stato il mio malandato e privilegiatissimo paziente.
Non è importante in questa sede riferire la sua diagnosi né precisare che in alcun modo la sua privacy verrà violata.
Quello che voglio raccontare qui è che due amici e un fratello hanno preso di petto una situazione diventata ingestibile e se ne sono fatti carico, senza se e senza ma.
Uno di loro ha detto al mio paziente “Bro’, noi siamo l’hardware, pensiamo a tutto noi, ti accompagniamo, ti aspettiamo, ti sosteniamo economicamente, ti troviamo uno spazio dove puoi lavorare su te stesso serenamente, senza fonti di disturbo. Tu sei il software, fai il tuo, non preoccuparti per noi”.
Non mi sembrava vero che stessi ascoltando quelle parole d’oro che per tutta la serata che sarebbe giunta mi avrebbero condotto in un loop fatto di “Ma a me, quel discorso lì, chi me lo farebbe mai se ne avessi bisogno?”. Pur avendo la risposta in tasca, nel mio telefonino, non sono riuscita a smettere di pormi quell’interrogativo.
Il viaggio con questi ragazzi è iniziato. Loro saranno la famiglia del mio paziente, si sottoporranno a una modalità di Parent Training estremamente taylor made, se non fosse che probabilmente sarò io a imparare da loro.
Dal canto suo, il mio paziente ha goffamente risposto “Grazie bro’, resto umile”, come una voce fuori campo che non azzecca il momento giusto per recitare la sua battuta.
Io non sono riuscita a restare umile e per questo, ogni volta che uso il tag #facciolillavoropiùbellodelmondo, gongolo e mi sento fiera di poter onorare il valore del mestiere che ho scelto e che scelgo ogni giorno.
Grazie per avermi letto.